«Questo è uno degli angoli più belli del mar Ionio, uno dei posti più belli del mondo» dice Luigi disegnando nell’aria un gesto che abbraccia la costa fin dove l’occhio può arrivare. Il mare è tanto blu da sembrare finto; c’è chi fa il bagno, chi pesca, chi prende il sole e chi sta all’ombra dei pini piegati dal vento.
«E tu vieni spesso qua?»
«No, mai»
«Perché?»
«E che vengo a fare? Non ho tempo».
Luigi non ha tempo perché ha una missione importante da portare avanti. E, per quanto il Salento sia bello e casa sua sia a pochi metri dal mare, non può concedersi inutili distrazioni dalla sua marziale routine quotidiana.
Luigi Orabona adesso ha 78 anni e ha da poco terminato il suo romanzo L’Iveonte. L’ha iniziato a 18 anni e l’ha portato avanti esattamente per sessant’anni, dal 1961 al 2021.
Originario di Parete, in provincia di Caserta, ha lavorato per decenni a Varese, prima alle Poste e poi come maestro elementare, insegnando scienze e matematica. Dopo la pensione si è spostato per qualche anno nel suo paese natale nel casertano, e infine ha trovato il suo buon ritiro qua, nel profondo sud, in questo Salento metafisico, leggermente appartato dal casino dell’ultraturismo, in un posto che si chiama “Vacanze serene”. Luigi abita a Nardò, in via Omero.
«E a Varese sai dove abitavo? In via Dante».
Dovunque si trovasse, prima e dopo aver conosciuto sua moglie – l’amatissima Lisa Beatrice – qualunque lavoro facesse, qualsiasi piega prendesse la sua vita, Luigi per sessant’anni ha scritto, ogni giorno, il suo romanzo.
Ma chiamarlo romanzo non rende. Le numerose volte che gli ho chiesto di riassumerlo o di spiegarmelo non ne siamo mai venuti fuori. La definizione migliore che mi ha dato è «Dentro c’è tutto». Pausa. «Tutto».
Ho iniziato a parlare con lui mesi fa, anche se ero sulle sue tracce da oltre un anno. Non è stato facile scovarlo: è apparso ogni tanto sulle cronache locali e anche nel web si trovavano indizi della sua esistenza. Discussioni in alcuni forum, poesie, commenti, trafiletti sui quotidiani. Nei pochi articoli a lui dedicati nel titolo è sempre specificato “maestro elementare”. A corredo una sua foto con la faccia seria, quasi imbronciata, e nell’occhiello qualche dettaglio folkloristico da personaggio fuori dalle righe. La figura del maestro elementare è un topos del giornalismo capace di evocare quella provincia italiana fucina delle cose più strane ma rassicuranti, perfetta per gli articoli tappabuchi dei rotocalchi.
Più raccoglievo indizi e più mi chiedevo chi fosse veramente questo Luigi Orabona. Esisteva davvero? Poi ho trovato un numero di telefono.
«Hai spazio in casa?» mi chiese in una delle prime telefonate.
«Sì, abbastanza. Perché?»
«Perché voglio regalarti il mio romanzo».
Qualche giorno dopo il corriere ha suonato, sono andato ad aprire e ho sollevato un pacco molto pesante che ho faticosamente trascinato in salotto: otto grossi volumi dal dorso giallo per un totale di 8800 pagine. Messi in piedi uno sopra l’altro gli otto tomi dell’Iveonte sono alti quasi mezzo metro e pesano 10 kg: più o meno quanto un bambino di tre anni.
«Sono 14 milioni e 276mila caratteri, questo significa che è il romanzo più lungo della storia. È più lungo della Ricerca del tempo perduto di Proust, ed è lungo 11 volte i Promessi Sposi».
I numeri sono un’ossessione per Luigi; per ogni volume tiene sempre conto di quanti caratteri ci sono, quante parole, quante pagine, quanti capitoli.
Se dovessimo valutare solo le dimensioni dell’opera e l’incredibile ambizione, usando come metri di giudizio il peso e le dimensioni della sua fatica letteraria, Luigi Orabona sarebbe senza dubbio il più grande scrittore italiano vivente. Eppure, al netto di una ferrea disciplina, sembra averlo fatto senza sforzo, mosso da una passione bruciante e da una vera e propria “urgenza”: parola quasi sempre abusata, ma in questo caso aderente alla realtà. Per Luigi scrivere è davvero una questione di vita o di morte, una necessità fisiologica.
«Io ho bisogno dello scrivere, come i miei polmoni hanno bisogno di ossigeno. Restare senza scrivere è come vivere senza sogni e senza ideali».
Sessant’anni di lavoro, oltre 1300 personaggi per centinaia di trame ambientate in più galassie, “le quali vengono a incastonarsi nella trama principale dell’epico racconto come preziosi episodi permeati di raro pathos” come scrive lo stesso Luigi nella quarta di copertina.
Spesso si parla di romanzi-mondo: ecco, quello di Luigi è un romanzo-galassia.
Ma di cosa parla? Se volessimo limitarci a definizioni da critici letterari si potrebbe dire che è un’epopea mitologica, un romanzo fantasy con avventure e storie d’amore fuori dal tempo, con un eroe protagonista, Iveonte. Ma non siamo critici letterari, e ancora meno siamo gente che vuole limitarsi. Luigi è il contrario del limite: quando parla dell’Iveonte lo presenta semplicemente come “la più avvincente epopea di tutti i tempi”, letteralmente una reinvenzione dell’universo, e quando parla delle sue opere dice che per farle “ci vorrebbero dieci cervelli di Leonardo”. A volte sono sette, a volte di più: diciamo che usa il cervello del genio fiorentino come unità di misura della fatica, dell’impegno, dello sforzo intellettuale e dell’abnegazione necessaria per concentrarsi per tanto tempo su qualcosa di così intricato e complesso.
«Bello eh?» mi chiede ancora indicando il mare.
«Bellissimo».
«Andiamo via?»
Il mare è bello, ma il sole inizia a picchiarci la testa e decidiamo di andare a casa sua, che è davvero a due passi. Un giardino curatissimo con un lastricato in pietra, aiuole, siepi, palmizi e piante in fiore circondano una villetta a un solo piano, normalissima. Mentre parlo con sua moglie Lisa Beatrice vago con lo sguardo alla ricerca di indizi. Ci sarà qualcosa che lascia intuire che qua, dentro questa casa, è stato scritto un romanzo di oltre 14 milioni di caratteri e una trama impossibile da riassumere? No. Tutto è incredibilmente normale. Esattamente come Luigi: un simpatico signore in tuta da ginnastica, cordiale e per niente serioso come appare nelle foto, che ama le battute e i giochi di parole. Eppure non mollo: il diavolo è nei dettagli, ci dev’essere qualcosa.
«Bevi il caffè?»
«No, grazie. Un bicchiere d’acqua va bene».
In salotto c’è un mobiletto con ninnoli vari, piccole creazioni di cristallo, bomboniere, souvenir. Poi una credenza con i servizi di piatti, bicchieri e porcellane. Nella libreria enciclopedie di ogni genere, di quelle che si usano più per arredare che per essere consultate; ma nessun altro libro a parte quelli scritti da Luigi.
«C’era un’altra libreria», mi spiega Lisa Beatrice, «ma l’abbiamo messa via».
Alle pareti quadri di nature morte e paesaggi qualunque, poi un mazzo di carte («la sera, dopo cena, giochiamo a Scala quaranta»), qualche oggetto indispensabile, un divano e un televisore («non lo guardiamo quasi mai») e poco altro. Non è la scenografia che mi aspettavo.
Più fisso quegli oggetti così normali più capisco che forse è proprio questa la chiave del mondo di Luigi, l’ex maestro elementare che per tutta la vita ha vissuto migliaia di altre vite in diverse galassie. Più la sua vita qua, sul pianeta Terra, era normale e ordinaria, più era spettacolare ed epica la vita di Iveonte, l’invincibile guerriero. La sua ordinaria quotidianità sembra inversamente proporzionale a quella dell’epico e avventuroso mondo del suo romanzo.
«Io sono portato a scrivere soltanto ciò che è considerato inconoscibile oppure è frutto della mia pura fantasia» mi dice mentre apre il frigorifero più grande che io abbia mai visto per prendere il latte. E aggiunge: «I personaggi di Iveonte non sono ispirati a persone realmente esistenti. Quando lavoro, volo sopra il mio bianco cavallo alato, desideroso di estraniarmi dalla realtà e di rifugiarmi nel mio mondo interiore».
Questo significa che quando Luigi lavorava alle Poste, Iveonte si impossessava della Spada dell’Invincibilità nel Castello Maledetto e Kron ordinava ai gerark di distruggere l’impero dell’Ottaedro. Quando Luigi andava a fare le gite con la sua classe o partecipava a un collegio docenti, Iveonte combatteva eroicamente il malvagio mago Zegovut nella sua dimora di Illuxis. E mentre faceva un trasloco, spostando pacchi e scatoloni, Iveonte incontrava Tupok, il signore del Potere Cosmico, nel regno di Potenzior.
Quando tento di approfondire questo aspetto, quello della sua doppia vita, lui non mi segue, sminuisce, sorride, non pare interessato.
E va bene: cerco indizi altrove. Ad esempio tra le sue poesie. Perché, oltre ad avermi regalato l’Iveonte, Luigi mi ha inviato anche una sua raccolta di centinaia di liriche con migliaia di versi. «La raccolta in totale comprende 720 poesie e 27.760 versi. La mia intenzione è di terminarla e in quel caso arriverei a superare i 30.000 versi, ovvero il doppio di quelli della Divina Commedia, che ne ha 14.223».
Comunque, mentre in aereo sorvolavo la Puglia per andare a incontrarlo, leggevo queste sue poesie. Ne ha scritte soprattutto d’amore, tanto da definirsi “il poeta dell’amore”. Ma ce ne sono anche altre più introspettive. Una si intitola “Voglia di non essere”, che tra i primi versi dice: “voglio sentirmi libero / senza preoccupazioni, / svincolato perfino / dalla mia reale esistenza. / In realtà intendo vivere / completamente privo / di qualsiasi sensazione, / immerso nell’essenza / del mio non essere / e avvinghiato stretto / a ciò che non esiste / per smettere di sentire / attraverso i miei sensi”.
In “Sono stanco” esordisce con: “Sono stanco / di continuare a sentirmi dire / che la vita va presa per ciò che è”.
Ancora, in “Vivere di sogni”, ricorda di quando “Ragazzo e spensierato, / ero solito rintanarmi nelle favole della nonna”, per poi ripercorrere l’infanzia, la giovinezza e l’età adulta, dove “Adulto e pensieroso / trascorrevo la mia vita / dedito ai miei doveri”. E infine (ma si potrebbe continuare) in “Sentirsi poeta”: “Sentirsi poeta / è come vivere un’altra esistenza / parallela a quella normale / e dedita alla quotidianità”.
Il mondo dell’Iveonte da una parte; e la vita quotidiana, il tempo che passa, il lavoro, le bollette da pagare, dall’altra. Da una parte la fila al supermercato e il bollo auto, dall’altra la circoscrizione spaziale di Maser e Iveonte che eroicamente libera Rindella dalla malia dello sciamano Turpov.
Luigi versa il latte nel caffè e io gli chiedo quanto c’è di autobiografico in quelle ottomila pagine e quanto la sua vita esterna abbia influito nelle vicende del romanzo: praticamente nulla, dice subito.
«Nell’andare avanti con il mio Iveonte io navigavo nel mare della fantasia; invece gli eventi che mi coinvolgevano si svolgevano nella realtà, a volte amara a volte accettabile».
Allo stesso tempo, ammette che il personaggio di Iveonte, l’eroe protagonista dell’epopea, ovvero il guerriero invincibile, è quello che avrebbe voluto essere: «Ho creato il mio Iveonte appunto per fargli compiere quelle gesta che non mi sono permesse nella vita quotidiana. E poi, non è un nome bellissimo? È la prima cosa che ho pensato, il nome. Sapevo che l’eroe doveva avere un bel nome. Così ho inventato Iveonte. Poco tempo fa ho scoperto che c’è una ragazza nera su Facebook che si chiama così, Iveonte Whait, ora adolescente».
Quando Luigi ha iniziato l’Iveonte, scriveva a mano su quaderni, per poi ricopiare tutto con la macchina da scrivere. All’epoca aveva letto Salgari e Verne, ma fu la lettura dei poemi epici a fargli capire che non poteva accontentarsi di una sola vita, di un solo paese, di un solo pianeta, di una sola galassia.
«In realtà L’Iveonte non è il primo romanzo che ho scritto. Alle scuole medie scrissi sui quaderni circa trecento pagine dal titolo Le genti del Continente Maledetto attraverso i secoli che narravano le gesta degli abitanti dell’ipotetico continente scomparso di Lemuria. Non so che fine abbia fatto. In seguito alla lettura dei poemi l’Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme Liberata di Tasso decisi di crearne uno tutto mio, desideroso fin dall’inizio di farlo diventare l’opera epica più accattivante e coinvolgente di tutti i tempi».
Dalla piccola Parete, paesino in provincia di Caserta che all’epoca aveva quattromila abitanti, Luigi si trasferisce al nord, dove lavora per otto anni alle Poste. È là che conosce Lisa Beatrice. Si incontrano nell’agosto del 1973 e si sposano sei mesi dopo, nel marzo del 1974.
«Al matrimonio non invitammo nessuno, né parenti né amici. Ci fecero da testimoni il sagrestano della parrocchia e la signora che suonava il piano».
Successivamente verrà assunto come maestro elementare, lavoro che ha amato molto e che ha portato avanti con passione per 36 anni, senza però mai smettere di vivere in quell’altrove, senza mai smettere di scrivere.
«Eccettuate le rare volte che uscivo di casa con mia moglie, mi dedicavo alla scrittura delle mie opere per l’intero pomeriggio, ossia fino alle 20».
Molte ore, per decenni, necessarie a costruire un mondo incredibilmente complesso. Non solo per le tante avventure e i tanti personaggi, ma anche per la precisione maniacale con la quale Luigi ha inventato ogni singolo fantasioso dettaglio. Per averne un’idea basta sfogliare quelle che possiamo definire le pagine gialle dell’Iveonte, dove sono spiegati personaggi, creature e città presenti nel romanzo. Luigi ha inventato centinaia di pianeti e stelle, villaggi, popoli, etnie, gerarchie, luoghi misteriosi come la Valle dei sogni reali, dove si accede solo durante il sonno, ma dove ogni fatto avviene realmente, o il Varco Intercosmico, cioè il tunnel di comunicazione tra due universi paralleli.
I mostri sono descritti nei minimi dettagli: i Vectus ad esempio sono mostri stellari e “hanno un’estensione in lunghezza di venti metri e un diametro del corpo di cinque metri; mentre le loro braccia sono lunghe sei metri. La loro velocità è uguale a quella della luce, mentre la loro potenza distruttiva è di primo grado e può distruggere un’intera montagna. La gittata massima del loro potenziale energetico è di mille chilometri”.
Ci sono poi centinaia di oggetti parte dell’immaginario iveontiano, come lo “spost”, un “aggeggio manuale, usato dai sovrintendenti dei kosmicon per trasportare un mostro da un punto all’altro dell’impero. Una volta acceso, esso emette un raggio verde regolabile in lunghezza, che riesce a muoversi agevolmente all’interno dell’oculum per eseguire l’operazione accennata”.
Per non parlare della mappatura delle galassie e dei singoli luoghi, incredibilmente dettagliata. Ad esempio, l’Impero del Tetraedro, ovvero la parte di Kosmos in cui si stabiliscono le divinità benefiche, è formato da diciassette galassie suddivise in quattro circoscrizioni. Di ognuna conosciamo i singoli pianeti, le singole città e villaggi. Dietro un lavoro di questo tipo ci sono migliaia di ore a ticchettare sui tasti e uno spirito a metà tra il cartografo e l’impiegato del catasto.
Luigi mi spiega che negli anni è diventato sempre più difficile gestire tante trame e sottotrame, romanzi dentro altri romanzi, migliaia di luoghi, vicende intricate, nomi che spesso cambiavano e una linea narrativa così lunga: basti pensare che il protagonista, Iveonte, appare solo dopo 600 pagine.
«Tenevo sempre aggiornati i tre elenchi di nomi in ordine alfabetico, volendo evitare di creare dei doppioni».
La svolta arriva nel 2000, quando compra un computer. Da lì in poi tutto diventa più facile: cercare e sostituire un nome e tenere sotto controllo tutte le linee narrative. La parte più facile, dice, è scrivere: «Non programmo mai niente. Riparto sempre a occhi chiusi, completamente all’oscuro di quanto sto per scrivere. Quando digito la prima lettera, è come se io gettassi un secchio d’acqua su un terreno in pendio. Così, allo stesso modo dell’acqua che va formando tanti rivoli nel suo incessante scorrere, così la fantasia comincia a intrecciare le varie trame della mia impetuosa narrazione».
Gli chiedo se ora che ha finito l’Iveonte non senta un vuoto, visto che ha passato sessant’anni non solo a costruire minuziosamente quel mondo, ma a viverci dentro.
«Se devo essere sincero, al termine della mia immensa opera, non avverto alcun vuoto dentro di me, per la semplice ragione che gli episodi e i personaggi che la popolano sono rimasti nella mia mente e nel mio cuore, come se stessi assistendo al loro svolgersi in una situazione reale».
«E come hai capito di essere arrivato alla fine?»
«Ho preso coscienza della conclusione dell’opera non appena un senso di nostalgia e amarezza ha iniziato a pervadermi».
Nel finale Kronel, che è una divinità che si trasforma nella spada di Iveonte e se ne innamora, propone all’invincibile guerriero di andare nel tempo futuro a sconfiggere la cattiveria e il Male. Iveonte però rifiuta perché preferisce godersi finalmente la gioia e la tranquillità della propria famiglia.
«Da una parte avrei voluto che la storia continuasse, ma poi ho accettato la volontà del mio eroe, anche perché la mia tarda età non mi avrebbe permesso di affrontare le infinite peripezie a cui sarebbe andato incontro. E poi dovevo ultimare la Raubser».
E infatti Luigi, da quando ha terminato l’Iveonte, invece di riposarsi, si è dedicato completamente alla sua opera più ambiziosa: La Raubser, una lingua artificiale, che conduca l’umanità al monolinguismo.
Ha dedicato l’impresa ai “futuri bambini del nostro pianeta, con l’augurio che possano essi trovarsi un giorno nella condizione d’imparare la medesima lingua”. Frase che in Raubser si dice così: “Hai kurobik dont du aipl bulpes, voil guzev be udr paiur setalis gu kus unil oxeop ut taesi xez ser”.
L’idea iniziale, dice lui, gli è venuta perché aveva difficoltà a imparare altre lingue. Dunque, tipico ragionamento oraboniano, perché non inventarne una? È il 1993. Non contento di aver creato un gigantesco mondo immaginario dove vivere, Luigi decide di intervenire anche in questa realtà, nella dimensione dove vive con sua moglie, dove lavora, dove deve “prendere la vita per ciò che è”, quella “a volte amara a volte accettabile”, per migliorarla a suo modo. E allora ecco che si imbarca nell’invenzione di una nuova lingua, La Raubser. “La lingua artificiale che non teme confronti”, nonché “la più grande opera dell’ingegno creata fino ai giorni nostri” come da presentazione in pieno stile oraboniano.
«Direi che è una lingua quasi perfetta in ogni sua parte, risultando anche scientifica, come non lo è nessuna lingua parlata» spiega.
Dopo aver pranzato con delle buonissime lasagne ci spostiamo nel suo studio. Mi immagino pareti ricoperte dalle mappe delle galassie da lui inventate e da incomprensibili scritte in Raubser; schemi complessi che collegano tutti i personaggi dell’Iveonte, oggetti bizzarri, pile di libri e manoscritti, fogli sparsi ovunque. Invece entriamo in una stanza spoglia e anonima, molto ordinata, direi minimalista. C’è una piccola scrivania con un computer portatile, una stampante e un telefono. Niente di cartaceo in giro, a parte due rubriche. Luigi, infatti, non legge mai sulla carta e ha buttato tutti gli appunti e i dattiloscritti dell’Iveonte e delle altre sue opere. Alla mia domanda «Perché?» risponde semplicemente «E che me ne facevo?». Lisa Beatrice conferma: «Butta tutto! A momenti butta anche le mie cose!». Alle spalle della scrivania il quadro di un gatto; al centro dello studio un divano e poi una piccola libreria che contiene ovviamente L’Iveonte, ma anche il gioco “Il paroliere”, i DVD della serie Il Trono di Spade. E nient’altro.
Mentre accende il computer Luigi si lamenta ancora del poco tempo a disposizione per portare avanti i suoi progetti. Completata la grammatica e la parte scientifica della Raubser, sta portando avanti il vocabolario, ma le parole sono tante e il tempo mai abbastanza. «Io alle 6 di mattina a volte inizio già a lavorare. Per me ogni ora di sonno è un’ora tolta alla vita. Dicono tutti: il sonno fa bene, il sonno è vita. Mah, per voi. Per me è una perdita di tempo!».
Gli chiedo se, a parte gli sporadici articoli sui giornali, qualcuno si è seriamente interessato alla Raubser
«No. Ad essere sincero, non ci sono stati né studiosi, né linguisti né curiosi a voler conoscere qualcosa sulla lingua da me creata. Ricordo solo che nel 1997 uno studente universitario di lingue mi scrisse una lettera».
Questo avrebbe forse demotivato chiunque, ma non Luigi, che è andato avanti con metodo e abnegazione totale e, invincibile guerriero amanuense e traduttore, ogni giorno si dedica alla stesura del vocabolario, seguendo una routine precisa. Esce raramente, cammina nel cortile di casa mezz’ora la mattina e mezz’ora la sera. Per il resto del tempo si dedica a inventare parole. «In media sei ore al giorno, dipende». Quando piove e non può camminare fuori allora mette della musica e balla da solo nel suo studio per mezz’ora.
Una volta davanti al pc, non resisto alla tentazione di chiedergli di creare una parola in Raubser insieme. È presto fatto: ci sono ancora molte parole non tradotte, quindi ne prendiamo a caso una: subbia.
Sì, nemmeno noi sapevamo cosa volesse dire e siamo andati a cercare nel dizionario: la subbia è uno scalpello a punta quadra per la lavorazione della pietra o di materiali duri.
«Non è proprio una parola fondamentale» osservo.
«Ma vanno tradotte tutte» mi fa notare Luigi. «Tutte» aggiunge.
Dunque traduciamo subbia in Raubser e ora il vocabolario ha una parola in più: “arfub”, ovvero subbia, infilata tra “arfosi” (osannare) e “arfukaof” (ortomercato).
Uno dei tanti punti di forza di questa lingua, secondo Luigi, è la sua semplicità. Concependo le regole grammaticali ha puntato alla facilità di pronuncia e all’economicità. L’idea era di mettere in una parola più informazioni possibili usando il minor numero di segni grafici. Inoltre, non voleva che fosse una lingua statica, ma anzi una lingua che permetta di “essere applicata secondo le proprie esigenze” e che “consenta ogni evoluzione possibile”.
Ad esempio, in Raubser è possibile esprimere concetti astratti o complessi per cui in italiano dobbiamo ricorrere a più parole – o anche crearli. “Simpatia per il lavoro” in Raubser è semplicemente “boilur”.
Una delle intuizioni più semplici e interessanti è quella per la quale ogni coppia di vocaboli che esprimono due concetti opposti si leggono al contrario. Per capirci, amore in Raubser è “met”, odio è “tem”. Oppure bianco è “favet”, e dunque nero è “tevaf”, grande è “dret”, piccolo è “terd”. E così via.
Ma non è tutto.
«Secondo te, come potevo ottenere nei nomi degli animali e delle piante, costituiti da poche lettere, la loro genealogia, comprendente la loro famiglia, il loro ordine, la loro classe, il loro tipo (nei primi) e la loro divisione (nelle seconde) di appartenenza?» mi chiede Luigi, come se io potessi rispondere. «Prima c’è dovuto essere tutto uno studio approfondito della tassonomia animale e vegetale. Lo stesso lavoro c’è stato per ottenere nei nomi degli elementi chimici, anch’essi costituiti da poche lettere, il loro simbolo, il loro numero atomico, il peso atomico e altre notizie che li riguardavano».
Ad esempio, acqua in Raubser è “ebas”. Poche lettere, che ci dicono però molto: B e S sono idrogeno (xavaB) e ossigeno (navaS). La E iniziale significa che gli atomi di idrogeno sono due, mentre la A che l’atomo di ossigeno è uno. Dunque, abbiamo la parola, ma anche la formula chimica.
Un metodo simile lo utilizza per la parte geografica. I nomi degli Stati ci danno diverse informazioni, come il continente di appartenenza, la loro sigla, i kmq di superficie e perfino la posizione della capitale indicando latitudine e longitudine. Il Modesmac, che forse in italiano conoscete come Brasile, ci indica che appartiene al continente americano (le ultime due lettere, AC), la grandezza del territorio e la posizione della capitale Brasilia. Anche qua, basta imparare delle regole piuttosto semplici e saper leggere in Raubser. Cosa che al momento ovviamente sa fare solo Luigi.
Luigi ha anche risolto l’annoso problema del plurale maschile in italiano: c’è il genere promiscuo, dunque ad esempio i neonati maschi sono “li bent”, le neonate femmine “li bentien”, i neonati al plurale sia maschi che femmine “li bentiel”.
Mentre scorre le pagine sul computer appaiono migliaia di parole ancora da completare. «Non ho difficoltà a creare parole: considera che nell’Iveonte ho inventato 1845 nomi, tra personaggi e luoghi». In effetti, scorrendo l’infinita lista dei nomi e dei luoghi dell’Iveonte si rimane affascinati dalla varietà e dall’inventiva: Kenust, Beriesk, Pornuk, Dolren, Admur (dio degli omosessuali), Kronel, Nurdok, Kreop (dio degli strapazzi, ex dio delle illusioni), Loifen, Oskup, Puzzud, Rapos, Parakosm (universo parallelo di Kosmos), Opirgos, Landipur, Xoran e così via. Il suo gatto invece si chiama Pippo.
«Io e mia moglie non abbiamo avuto figli. Ma forse è stato destino: questo mi ha permesso di avere più tempo per scrivere».
Chiedo a Lisa se ha letto l’Iveonte: «Certo, due volte! E mi è piaciuto molto».
Lei è la sua lettrice ufficiale da sempre, di tutte le sue opere, e l’ha aiutato a correggere alcuni refusi e a rendere più scorrevoli alcuni passaggi. Ma chi altro ha letto i 15 milioni di caratteri dell’Iveonte? La colossale epopea è stata letta di sicuro da una loro vicina di casa, («l’ha letto tutto d’un fiato», mi dice Luigi) e da una “amica di Facebook”, sua lettrice appassionata da vent’anni che negli anni ha seguito l’evolversi di questa galassia-libro. Di altri lettori o lettrici, non abbiamo notizie certe.
Gli chiedo se in tutti questi anni qualcuno, un collega magari, un amico o un parente, si sia interessato all’Iveonte, e anche alle sue poesie e alla Raubser.
«In verità, mai nessun mio collega si è preso la briga d’interessarsi alle mie opere. Al riguardo, non sono mai riuscito a capire se per gelosia, per invidia oppure perché davvero non avevano tempo di leggerle. Posso affermare che lo stesso atteggiamento c’è stato nei confronti delle mie opere anche da parte di amici e parenti. Quando gliene parlavo, mai nessuno si è fatto prendere dalla curiosità di conoscere le cose che scrivevo».
In una delle sue poesie introspettive tratte dalla raccolta “Sensazioni dall’inconscio” Luigi scrive: “Sono stufo di stare con persone che forse non meritano la mia stima e la mia fiducia, non interessandosi esse a tutto ciò che scrivo; anzi, preferiscono ignorarlo e si comportano come se io non ponessi mai mano alla penna”.
Allo stesso tempo, in passato ha tentato contatti con case editrici: ma si sa, gli scrittori sono tanti, i manoscritti sono migliaia e figuriamoci quando arriva un malloppo come L’Iveonte… Dopo diverse delusioni Luigi ha optato per la vendita online e l’autopubblicazione on demand: il libro cartaceo viene stampato solo nel momento in cui viene ordinato. Questo permette oltretutto di poter correggere eventuali errori o modificare alcuni passaggi e avere versioni sempre aggiornate dei volumi. Ciò significa che teoricamente esistono più versioni dell’Iveonte, anche se non sappiamo quante ce ne sono in giro – e se ce ne sono.
Con gli scrittori l’argomento libri venduti è sempre molto delicato, quindi mi ci avvicino con i piedi di piombo, ma capisco subito che a Luigi non interessa affatto.
«Più che il denaro che potrei guadagnare dalla vendita dei miei libri, in primo luogo m’interessa la loro lettura da parte di un vastissimo pubblico».
Per questo motivo nel 2005 intraprende un’altra missione senza limiti: mettere online tutte le sue opere. Si tratta di migliaia di pagine – per l’esattezza 2171 –, un sito enorme e labirintico, che decide di costruirsi da solo (www.luigiorabona.com). Impara il linguaggio del Web, l’HTML, e costruisce il suo sito che da allora aggiorna costantemente man mano che completa gli scritti o trova degli errori. Se vuole modificare una singola parola, individua la pagina che gli interessa tra le migliaia presenti, la apre con blocco note e interviene direttamente sul codice. Un metodo efficace e artigianale da abile scriba digitale.
«Ho imparato tutto da solo» ci tiene a precisare.
Gli chiedo di mostrarmi i file originali dell’Iveonte. Davanti ai miei occhi scorrono migliaia di file HTML: è un po’ come guardare il codice sorgente di Matrix. Le mappe che illustrano le galassie dove il romanzo è ambientato, con l’impero dell’ottaedro, l’impero del tetraedro, la galassia neutrale e tutti i vari pianeti, le ha realizzate con Paint.
Chiedo a Luigi se ha mai pensato di tradurre l’Iveonte nella lingua Raubser.
«Devo considerare la tua domanda uno scherzo? La Raubser non è uno dei tanti tentativi di lingua artificiale. In tutti i sensi, essa è superiore a qualsiasi lingua parlata. Quindi dovrei impararla perfettamente prima di tradurre Iveonte nella lingua Raubser. Inoltre, data anche la mia tarda età non avrei né le forze fisiche né il tempo materiale».
Lascio Luigi e Lisa Beatrice e il mare del Salento e qualche ora dopo sono in aeroporto che attendo il mio volo. Sfoglio ancora le poesie e capito su una intitolata “Oramai ci siamo”, dove Luigi affronta il tema per eccellenza, la morte: “Oramai si affretta il tempo che mi obbligherà ad affrontare la fase finale della mia esistenza” esordisce. Per poi prendere atto che a un certo punto le sue forze lo abbandoneranno e così “ogni intraprendenza attiva della mia prolifica fantasia”.
Guardo una sua mail di qualche mese fa con alcune fotografie di lui da bambino e da ragazzo. Nella mail mi raccontava della sua infanzia: “Mia madre era casalinga e mio padre aveva un piccolo negozio. Avevano conseguito entrambi la licenza di quinta elementare. Io e le mie due sorelline Rita ed Elvira ci ammalammo di una infezione viscerale. Loro morirono, mentre io ero quasi morto, per cui cominciarono a piangermi. Allora intervenne questo mio parente e gridò a tutti: Egli non è morto; anzi, vivrà e diventerà il più grande uomo di Parete!“.
Luigi proviene da una famiglia numerosa e ha avuto un’infanzia costellata da morte e dolore. “In famiglia, oltre a me e le mie sorelline morte, c’erano ancora altri sette fratelli più grandi, tre maschi e quattro femmine. All’età di 15 anni, quando frequentava la terza media, una delle sorelle morì di meningite tubercolare. A quel tempo, anch’io, che avevo 6 anni, mi ammalai di tbc, ma nessuno se ne accorse e guarii senza fare alcuna cura. Lo venimmo a sapere solo anni dopo. Io e i miei fratelli in seguito ci ammalammo anche di epatite B: io ero divenuto portatore sano, mentre i miei fratelli ne erano rimasti affetti allo stato latente e morirono di cirrosi epatica, a causa della loro epatite non curata.”
Mentre rileggo la mail squilla il telefono: è lui. Penso che voglia sapere se sono già partito, ma invece attacca con una raffica di cifre enormi che non riesco a seguire: un milione e settecentotrentaquattro mila, un milione e ottocentosedicimila e così via, che si mescolano agli annunci degli altoparlanti dell’aeroporto e al chiacchiericcio dei passeggeri in attesa intorno a me.
«Luigi, sono in aeroporto, non ti sento bene, è meglio se mi mandi una mail» gli dico. Pochissimi minuti dopo ricevo una mail con il numero esatto dei caratteri di ogni singolo capitolo dell’Iveonte. Riprendo in mano la poesia di prima, “Oramai ci siamo”, che si conclude con i seguenti versi: “Del mio tiepido essere vivente non potrà che restare soltanto il ricordo di amici e parenti”.
Se togliamo le poche ore di sonno, e le ore di veglia passate a scrivere, Luigi ha trascorso più tempo nel mondo dell’Iveonte che in quello reale. La sua opera smisurata e fantastica sembra il frutto di un totale rifiuto della “vita per ciò che è”. Partendo da Parete, Luigi ha fatto della propria vita un romanzo, e di un romanzo la propria vita. E finché ci sarà anche un solo lettore o lettrice che ne sfoglierà qualche pagina, quel romanzo esisterà. E se è vero, come amava ripetere un grande artista salentino, che “non bisogna produrre capolavori, ma essere capolavori”, Luigi Orabona è senza dubbio un capolavoro.
Morte in Raubser si dice kaud, dunque vita duak.






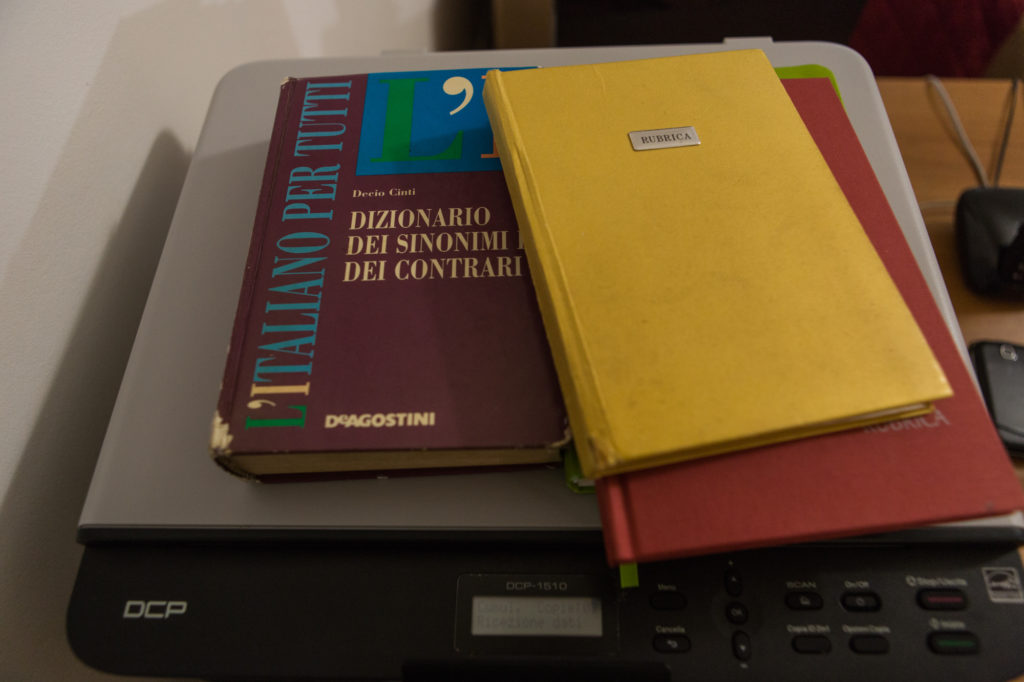





«Questo è uno degli angoli più belli del mar Ionio, uno dei posti più belli del mondo» dice Luigi disegnando nell’aria un gesto che abbraccia la costa fin dove l’occhio può arrivare. Il mare è tanto blu da sembrare finto; c’è chi fa il bagno, chi pesca, chi prende il sole e chi sta all’ombra dei pini piegati dal vento.
«E tu vieni spesso qua?»
«No, mai»
«Perché?»
«E che vengo a fare? Non ho tempo».
Luigi non ha tempo perché ha una missione importante da portare avanti. E, per quanto il Salento sia bello e casa sua sia a pochi metri dal mare, non può concedersi inutili distrazioni dalla sua marziale routine quotidiana.
Luigi Orabona adesso ha 78 anni e ha da poco terminato il suo romanzo L’Iveonte. L’ha iniziato a 18 anni e l’ha portato avanti esattamente per sessant’anni, dal 1961 al 2021.
Originario di Parete, in provincia di Caserta, ha lavorato per decenni a Varese, prima alle Poste e poi come maestro elementare, insegnando scienze e matematica. Dopo la pensione si è spostato per qualche anno nel suo paese natale nel casertano, e infine ha trovato il suo buon ritiro qua, nel profondo sud, in questo Salento metafisico, leggermente appartato dal casino dell’ultraturismo, in un posto che si chiama “Vacanze serene”. Luigi abita a Nardò, in via Omero.
«E a Varese sai dove abitavo? In via Dante».
Dovunque si trovasse, prima e dopo aver conosciuto sua moglie – l’amatissima Lisa Beatrice – qualunque lavoro facesse, qualsiasi piega prendesse la sua vita, Luigi per sessant’anni ha scritto, ogni giorno, il suo romanzo.
Ma chiamarlo romanzo non rende. Le numerose volte che gli ho chiesto di riassumerlo o di spiegarmelo non ne siamo mai venuti fuori. La definizione migliore che mi ha dato è «Dentro c’è tutto». Pausa. «Tutto».

Ho iniziato a parlare con lui mesi fa, anche se ero sulle sue tracce da oltre un anno. Non è stato facile scovarlo: è apparso ogni tanto sulle cronache locali e anche nel web si trovavano indizi della sua esistenza. Discussioni in alcuni forum, poesie, commenti, trafiletti sui quotidiani. Nei pochi articoli a lui dedicati nel titolo è sempre specificato “maestro elementare”. A corredo una sua foto con la faccia seria, quasi imbronciata, e nell’occhiello qualche dettaglio folkloristico da personaggio fuori dalle righe. La figura del maestro elementare è un topos del giornalismo capace di evocare quella provincia italiana fucina delle cose più strane ma rassicuranti, perfetta per gli articoli tappabuchi dei rotocalchi.
Più raccoglievo indizi e più mi chiedevo chi fosse veramente questo Luigi Orabona. Esisteva davvero? Poi ho trovato un numero di telefono.
Luigi Orabona adesso ha 78 anni e ha da poco terminato il suo romanzo L’Iveonte. L’ha iniziato a 18 anni e l’ha portato avanti esattamente per sessant’anni, dal 1961 al 2021.
«Hai spazio in casa?» mi chiese in una delle prime telefonate.
«Sì, abbastanza. Perché?»
«Perché voglio regalarti il mio romanzo».
Qualche giorno dopo il corriere ha suonato, sono andato ad aprire e ho sollevato un pacco molto pesante che ho faticosamente trascinato in salotto: otto grossi volumi dal dorso giallo per un totale di 8800 pagine. Messi in piedi uno sopra l’altro gli otto tomi dell’Iveonte sono alti quasi mezzo metro e pesano 10 kg: più o meno quanto un bambino di tre anni.
«Sono 14 milioni e 276mila caratteri, questo significa che è il romanzo più lungo della storia. È più lungo della Ricerca del tempo perduto di Proust, ed è lungo 11 volte i Promessi Sposi».
I numeri sono un’ossessione per Luigi; per ogni volume tiene sempre conto di quanti caratteri ci sono, quante parole, quante pagine, quanti capitoli.
Se dovessimo valutare solo le dimensioni dell’opera e l’incredibile ambizione, usando come metri di giudizio il peso e le dimensioni della sua fatica letteraria, Luigi Orabona sarebbe senza dubbio il più grande scrittore italiano vivente. Eppure, al netto di una ferrea disciplina, sembra averlo fatto senza sforzo, mosso da una passione bruciante e da una vera e propria “urgenza”: parola quasi sempre abusata, ma in questo caso aderente alla realtà. Per Luigi scrivere è davvero una questione di vita o di morte, una necessità fisiologica.
«Io ho bisogno dello scrivere, come i miei polmoni hanno bisogno di ossigeno. Restare senza scrivere è come vivere senza sogni e senza ideali».

Sessant’anni di lavoro, oltre 1300 personaggi per centinaia di trame ambientate in più galassie, “le quali vengono a incastonarsi nella trama principale dell’epico racconto come preziosi episodi permeati di raro pathos” come scrive lo stesso Luigi nella quarta di copertina.
Spesso si parla di romanzi-mondo: ecco, quello di Luigi è un romanzo-galassia.
Ma di cosa parla? Se volessimo limitarci a definizioni da critici letterari si potrebbe dire che è un’epopea mitologica, un romanzo fantasy con avventure e storie d’amore fuori dal tempo, con un eroe protagonista, Iveonte. Ma non siamo critici letterari, e ancora meno siamo gente che vuole limitarsi. Luigi è il contrario del limite: quando parla dell’Iveonte lo presenta semplicemente come “la più avvincente epopea di tutti i tempi”, letteralmente una reinvenzione dell’universo, e quando parla delle sue opere dice che per farle “ci vorrebbero dieci cervelli di Leonardo”. A volte sono sette, a volte di più: diciamo che usa il cervello del genio fiorentino come unità di misura della fatica, dell’impegno, dello sforzo intellettuale e dell’abnegazione necessaria per concentrarsi per tanto tempo su qualcosa di così intricato e complesso.
«Bello eh?» mi chiede ancora indicando il mare.
«Bellissimo».
«Andiamo via?»
Il mare è bello, ma il sole inizia a picchiarci la testa e decidiamo di andare a casa sua, che è davvero a due passi. Un giardino curatissimo con un lastricato in pietra, aiuole, siepi, palmizi e piante in fiore circondano una villetta a un solo piano, normalissima. Mentre parlo con sua moglie Lisa Beatrice vago con lo sguardo alla ricerca di indizi. Ci sarà qualcosa che lascia intuire che qua, dentro questa casa, è stato scritto un romanzo di oltre 14 milioni di caratteri e una trama impossibile da riassumere? No. Tutto è incredibilmente normale. Esattamente come Luigi: un simpatico signore in tuta da ginnastica, cordiale e per niente serioso come appare nelle foto, che ama le battute e i giochi di parole. Eppure non mollo: il diavolo è nei dettagli, ci dev’essere qualcosa.

«Bevi il caffè?»
«No, grazie. Un bicchiere d’acqua va bene».
In salotto c’è un mobiletto con ninnoli vari, piccole creazioni di cristallo, bomboniere, souvenir. Poi una credenza con i servizi di piatti, bicchieri e porcellane. Nella libreria enciclopedie di ogni genere, di quelle che si usano più per arredare che per essere consultate; ma nessun altro libro a parte quelli scritti da Luigi.
«C’era un’altra libreria», mi spiega Lisa Beatrice, «ma l’abbiamo messa via».
Alle pareti quadri di nature morte e paesaggi qualunque, poi un mazzo di carte («la sera, dopo cena, giochiamo a Scala quaranta»), qualche oggetto indispensabile, un divano e un televisore («non lo guardiamo quasi mai») e poco altro. Non è la scenografia che mi aspettavo.
“Sono 14 milioni e 276 mila caratteri, questo significa che è il romanzo più lungo della storia”
Più fisso quegli oggetti così normali più capisco che forse è proprio questa la chiave del mondo di Luigi, l’ex maestro elementare che per tutta la vita ha vissuto migliaia di altre vite in diverse galassie. Più la sua vita qua, sul pianeta Terra, era normale e ordinaria, più era spettacolare ed epica la vita di Iveonte, l’invincibile guerriero. La sua ordinaria quotidianità sembra inversamente proporzionale a quella dell’epico e avventuroso mondo del suo romanzo.
«Io sono portato a scrivere soltanto ciò che è considerato inconoscibile oppure è frutto della mia pura fantasia» mi dice mentre apre il frigorifero più grande che io abbia mai visto per prendere il latte. E aggiunge: «I personaggi di Iveonte non sono ispirati a persone realmente esistenti. Quando lavoro, volo sopra il mio bianco cavallo alato, desideroso di estraniarmi dalla realtà e di rifugiarmi nel mio mondo interiore».
Questo significa che quando Luigi lavorava alle Poste, Iveonte si impossessava della Spada dell’Invincibilità nel Castello Maledetto e Kron ordinava ai gerark di distruggere l’impero dell’Ottaedro. Quando Luigi andava a fare le gite con la sua classe o partecipava a un collegio docenti, Iveonte combatteva eroicamente il malvagio mago Zegovut nella sua dimora di Illuxis. E mentre faceva un trasloco, spostando pacchi e scatoloni, Iveonte incontrava Tupok, il signore del Potere Cosmico, nel regno di Potenzior.

Quando tento di approfondire questo aspetto, quello della sua doppia vita, lui non mi segue, sminuisce, sorride, non pare interessato.
E va bene: cerco indizi altrove. Ad esempio tra le sue poesie. Perché, oltre ad avermi regalato l’Iveonte, Luigi mi ha inviato anche una sua raccolta di centinaia di liriche con migliaia di versi. «La raccolta in totale comprende 720 poesie e 27.760 versi. La mia intenzione è di terminarla e in quel caso arriverei a superare i 30.000 versi, ovvero il doppio di quelli della Divina Commedia, che ne ha 14.223».
Comunque, mentre in aereo sorvolavo la Puglia per andare a incontrarlo, leggevo queste sue poesie. Ne ha scritte soprattutto d’amore, tanto da definirsi “il poeta dell’amore”. Ma ce ne sono anche altre più introspettive. Una si intitola “Voglia di non essere”, che tra i primi versi dice: “voglio sentirmi libero / senza preoccupazioni, / svincolato perfino / dalla mia reale esistenza. / In realtà intendo vivere / completamente privo / di qualsiasi sensazione, / immerso nell’essenza / del mio non essere / e avvinghiato stretto / a ciò che non esiste / per smettere di sentire / attraverso i miei sensi”.
In “Sono stanco” esordisce con: “Sono stanco / di continuare a sentirmi dire / che la vita va presa per ciò che è”.
Ancora, in “Vivere di sogni”, ricorda di quando “Ragazzo e spensierato, / ero solito rintanarmi nelle favole della nonna”, per poi ripercorrere l’infanzia, la giovinezza e l’età adulta, dove “Adulto e pensieroso / trascorrevo la mia vita / dedito ai miei doveri”. E infine (ma si potrebbe continuare) in “Sentirsi poeta”: “Sentirsi poeta / è come vivere un’altra esistenza / parallela a quella normale / e dedita alla quotidianità”.
Il mondo dell’Iveonte da una parte; e la vita quotidiana, il tempo che passa, il lavoro, le bollette da pagare, dall’altra. Da una parte la fila al supermercato e il bollo auto, dall’altra la circoscrizione spaziale di Maser e Iveonte che eroicamente libera Rindella dalla malia dello sciamano Turpov.
Luigi versa il latte nel caffè e io gli chiedo quanto c’è di autobiografico in quelle ottomila pagine e quanto la sua vita esterna abbia influito nelle vicende del romanzo: praticamente nulla, dice subito.
«Nell’andare avanti con il mio Iveonte io navigavo nel mare della fantasia; invece gli eventi che mi coinvolgevano si svolgevano nella realtà, a volte amara a volte accettabile».
Allo stesso tempo, ammette che il personaggio di Iveonte, l’eroe protagonista dell’epopea, ovvero il guerriero invincibile, è quello che avrebbe voluto essere: «Ho creato il mio Iveonte appunto per fargli compiere quelle gesta che non mi sono permesse nella vita quotidiana. E poi, non è un nome bellissimo? È la prima cosa che ho pensato, il nome. Sapevo che l’eroe doveva avere un bel nome. Così ho inventato Iveonte. Poco tempo fa ho scoperto che c’è una ragazza nera su Facebook che si chiama così, Iveonte Whait, ora adolescente».
“Sono stanco / di continuare a sentirmi dire / che la vita va presa per ciò che è”
Quando Luigi ha iniziato l’Iveonte, scriveva a mano su quaderni, per poi ricopiare tutto con la macchina da scrivere. All’epoca aveva letto Salgari e Verne, ma fu la lettura dei poemi epici a fargli capire che non poteva accontentarsi di una sola vita, di un solo paese, di un solo pianeta, di una sola galassia.
«In realtà L’Iveonte non è il primo romanzo che ho scritto. Alle scuole medie scrissi sui quaderni circa trecento pagine dal titolo Le genti del Continente Maledetto attraverso i secoli che narravano le gesta degli abitanti dell’ipotetico continente scomparso di Lemuria. Non so che fine abbia fatto. In seguito alla lettura dei poemi l’Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme Liberata di Tasso decisi di crearne uno tutto mio, desideroso fin dall’inizio di farlo diventare l’opera epica più accattivante e coinvolgente di tutti i tempi».

Dalla piccola Parete, paesino in provincia di Caserta che all’epoca aveva quattromila abitanti, Luigi si trasferisce al nord, dove lavora per otto anni alle Poste. È là che conosce Lisa Beatrice. Si incontrano nell’agosto del 1973 e si sposano sei mesi dopo, nel marzo del 1974.
«Al matrimonio non invitammo nessuno, né parenti né amici. Ci fecero da testimoni il sagrestano della parrocchia e la signora che suonava il piano».
Successivamente verrà assunto come maestro elementare, lavoro che ha amato molto e che ha portato avanti con passione per 36 anni, senza però mai smettere di vivere in quell’altrove, senza mai smettere di scrivere.
«Eccettuate le rare volte che uscivo di casa con mia moglie, mi dedicavo alla scrittura delle mie opere per l’intero pomeriggio, ossia fino alle 20».
Molte ore, per decenni, necessarie a costruire un mondo incredibilmente complesso. Non solo per le tante avventure e i tanti personaggi, ma anche per la precisione maniacale con la quale Luigi ha inventato ogni singolo fantasioso dettaglio. Per averne un’idea basta sfogliare quelle che possiamo definire le pagine gialle dell’Iveonte, dove sono spiegati personaggi, creature e città presenti nel romanzo. Luigi ha inventato centinaia di pianeti e stelle, villaggi, popoli, etnie, gerarchie, luoghi misteriosi come la Valle dei sogni reali, dove si accede solo durante il sonno, ma dove ogni fatto avviene realmente, o il Varco Intercosmico, cioè il tunnel di comunicazione tra due universi paralleli.
I mostri sono descritti nei minimi dettagli: i Vectus ad esempio sono mostri stellari e “hanno un’estensione in lunghezza di venti metri e un diametro del corpo di cinque metri; mentre le loro braccia sono lunghe sei metri. La loro velocità è uguale a quella della luce, mentre la loro potenza distruttiva è di primo grado e può distruggere un’intera montagna. La gittata massima del loro potenziale energetico è di mille chilometri”.
Ci sono poi centinaia di oggetti parte dell’immaginario iveontiano, come lo “spost”, un “aggeggio manuale, usato dai sovrintendenti dei kosmicon per trasportare un mostro da un punto all’altro dell’impero. Una volta acceso, esso emette un raggio verde regolabile in lunghezza, che riesce a muoversi agevolmente all’interno dell’oculum per eseguire l’operazione accennata”.
Per non parlare della mappatura delle galassie e dei singoli luoghi, incredibilmente dettagliata. Ad esempio, l’Impero del Tetraedro, ovvero la parte di Kosmos in cui si stabiliscono le divinità benefiche, è formato da diciassette galassie suddivise in quattro circoscrizioni. Di ognuna conosciamo i singoli pianeti, le singole città e villaggi. Dietro un lavoro di questo tipo ci sono migliaia di ore a ticchettare sui tasti e uno spirito a metà tra il cartografo e l’impiegato del catasto.

Luigi mi spiega che negli anni è diventato sempre più difficile gestire tante trame e sottotrame, romanzi dentro altri romanzi, migliaia di luoghi, vicende intricate, nomi che spesso cambiavano e una linea narrativa così lunga: basti pensare che il protagonista, Iveonte, appare solo dopo 600 pagine.
«Tenevo sempre aggiornati i tre elenchi di nomi in ordine alfabetico, volendo evitare di creare dei doppioni».
La svolta arriva nel 2000, quando compra un computer. Da lì in poi tutto diventa più facile: cercare e sostituire un nome e tenere sotto controllo tutte le linee narrative. La parte più facile, dice, è scrivere: «Non programmo mai niente. Riparto sempre a occhi chiusi, completamente all’oscuro di quanto sto per scrivere. Quando digito la prima lettera, è come se io gettassi un secchio d’acqua su un terreno in pendio. Così, allo stesso modo dell’acqua che va formando tanti rivoli nel suo incessante scorrere, così la fantasia comincia a intrecciare le varie trame della mia impetuosa narrazione».
Gli chiedo se ora che ha finito l’Iveonte non senta un vuoto, visto che ha passato sessant’anni non solo a costruire minuziosamente quel mondo, ma a viverci dentro.
«Se devo essere sincero, al termine della mia immensa opera, non avverto alcun vuoto dentro di me, per la semplice ragione che gli episodi e i personaggi che la popolano sono rimasti nella mia mente e nel mio cuore, come se stessi assistendo al loro svolgersi in una situazione reale».
«E come hai capito di essere arrivato alla fine?»
«Ho preso coscienza della conclusione dell’opera non appena un senso di nostalgia e amarezza ha iniziato a pervadermi».
Nel finale Kronel, che è una divinità che si trasforma nella spada di Iveonte e se ne innamora, propone all’invincibile guerriero di andare nel tempo futuro a sconfiggere la cattiveria e il Male. Iveonte però rifiuta perché preferisce godersi finalmente la gioia e la tranquillità della propria famiglia.
«Da una parte avrei voluto che la storia continuasse, ma poi ho accettato la volontà del mio eroe, anche perché la mia tarda età non mi avrebbe permesso di affrontare le infinite peripezie a cui sarebbe andato incontro. E poi dovevo ultimare la Raubser».
E infatti Luigi, da quando ha terminato l’Iveonte, invece di riposarsi, si è dedicato completamente alla sua opera più ambiziosa: La Raubser, una lingua artificiale, che conduca l’umanità al monolinguismo.
Ha dedicato l’impresa ai “futuri bambini del nostro pianeta, con l’augurio che possano essi trovarsi un giorno nella condizione d’imparare la medesima lingua”. Frase che in Raubser si dice così: “Hai kurobik dont du aipl bulpes, voil guzev be udr paiur setalis gu kus unil oxeop ut taesi xez ser”.
L’idea iniziale, dice lui, gli è venuta perché aveva difficoltà a imparare altre lingue. Dunque, tipico ragionamento oraboniano, perché non inventarne una? È il 1993. Non contento di aver creato un gigantesco mondo immaginario dove vivere, Luigi decide di intervenire anche in questa realtà, nella dimensione dove vive con sua moglie, dove lavora, dove deve “prendere la vita per ciò che è”, quella “a volte amara a volte accettabile”, per migliorarla a suo modo. E allora ecco che si imbarca nell’invenzione di una nuova lingua, La Raubser. “La lingua artificiale che non teme confronti”, nonché “la più grande opera dell’ingegno creata fino ai giorni nostri” come da presentazione in pieno stile oraboniano.
«Direi che è una lingua quasi perfetta in ogni sua parte, risultando anche scientifica, come non lo è nessuna lingua parlata» spiega.
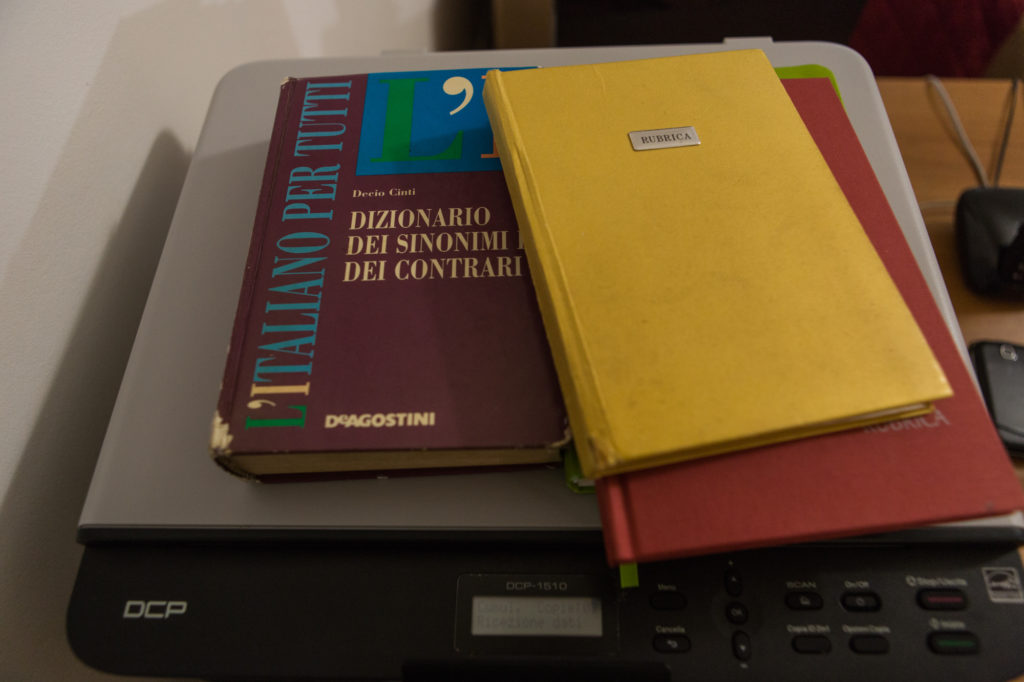
“Ho preso coscienza della conclusione dell’opera non appena un senso di nostalgia e amarezza ha iniziato a pervadermi”
Dopo aver pranzato con delle buonissime lasagne ci spostiamo nel suo studio. Mi immagino pareti ricoperte dalle mappe delle galassie da lui inventate e da incomprensibili scritte in Raubser; schemi complessi che collegano tutti i personaggi dell’Iveonte, oggetti bizzarri, pile di libri e manoscritti, fogli sparsi ovunque. Invece entriamo in una stanza spoglia e anonima, molto ordinata, direi minimalista. C’è una piccola scrivania con un computer portatile, una stampante e un telefono. Niente di cartaceo in giro, a parte due rubriche. Luigi, infatti, non legge mai sulla carta e ha buttato tutti gli appunti e i dattiloscritti dell’Iveonte e delle altre sue opere. Alla mia domanda «Perché?» risponde semplicemente «E che me ne facevo?». Lisa Beatrice conferma: «Butta tutto! A momenti butta anche le mie cose!». Alle spalle della scrivania il quadro di un gatto; al centro dello studio un divano e poi una piccola libreria che contiene ovviamente L’Iveonte, ma anche il gioco “Il paroliere”, i DVD della serie Il Trono di Spade. E nient’altro.
Mentre accende il computer Luigi si lamenta ancora del poco tempo a disposizione per portare avanti i suoi progetti. Completata la grammatica e la parte scientifica della Raubser, sta portando avanti il vocabolario, ma le parole sono tante e il tempo mai abbastanza. «Io alle 6 di mattina a volte inizio già a lavorare. Per me ogni ora di sonno è un’ora tolta alla vita. Dicono tutti: il sonno fa bene, il sonno è vita. Mah, per voi. Per me è una perdita di tempo!».
Gli chiedo se, a parte gli sporadici articoli sui giornali, qualcuno si è seriamente interessato alla Raubser
«No. Ad essere sincero, non ci sono stati né studiosi, né linguisti né curiosi a voler conoscere qualcosa sulla lingua da me creata. Ricordo solo che nel 1997 uno studente universitario di lingue mi scrisse una lettera».
Questo avrebbe forse demotivato chiunque, ma non Luigi, che è andato avanti con metodo e abnegazione totale e, invincibile guerriero amanuense e traduttore, ogni giorno si dedica alla stesura del vocabolario, seguendo una routine precisa. Esce raramente, cammina nel cortile di casa mezz’ora la mattina e mezz’ora la sera. Per il resto del tempo si dedica a inventare parole. «In media sei ore al giorno, dipende». Quando piove e non può camminare fuori allora mette della musica e balla da solo nel suo studio per mezz’ora.

Una volta davanti al pc, non resisto alla tentazione di chiedergli di creare una parola in Raubser insieme. È presto fatto: ci sono ancora molte parole non tradotte, quindi ne prendiamo a caso una: subbia.
Sì, nemmeno noi sapevamo cosa volesse dire e siamo andati a cercare nel dizionario: la subbia è uno scalpello a punta quadra per la lavorazione della pietra o di materiali duri.
«Non è proprio una parola fondamentale» osservo.
«Ma vanno tradotte tutte» mi fa notare Luigi. «Tutte» aggiunge.
Dunque traduciamo subbia in Raubser e ora il vocabolario ha una parola in più: “arfub”, ovvero subbia, infilata tra “arfosi” (osannare) e “arfukaof” (ortomercato).
Uno dei tanti punti di forza di questa lingua, secondo Luigi, è la sua semplicità. Concependo le regole grammaticali ha puntato alla facilità di pronuncia e all’economicità. L’idea era di mettere in una parola più informazioni possibili usando il minor numero di segni grafici. Inoltre, non voleva che fosse una lingua statica, ma anzi una lingua che permetta di “essere applicata secondo le proprie esigenze” e che “consenta ogni evoluzione possibile”.
Ad esempio, in Raubser è possibile esprimere concetti astratti o complessi per cui in italiano dobbiamo ricorrere a più parole – o anche crearli. “Simpatia per il lavoro” in Raubser è semplicemente “boilur”.
Una delle intuizioni più semplici e interessanti è quella per la quale ogni coppia di vocaboli che esprimono due concetti opposti si leggono al contrario. Per capirci, amore in Raubser è “met”, odio è “tem”. Oppure bianco è “favet”, e dunque nero è “tevaf”, grande è “dret”, piccolo è “terd”. E così via.
Ma non è tutto.
«Secondo te, come potevo ottenere nei nomi degli animali e delle piante, costituiti da poche lettere, la loro genealogia, comprendente la loro famiglia, il loro ordine, la loro classe, il loro tipo (nei primi) e la loro divisione (nelle seconde) di appartenenza?» mi chiede Luigi, come se io potessi rispondere. «Prima c’è dovuto essere tutto uno studio approfondito della tassonomia animale e vegetale. Lo stesso lavoro c’è stato per ottenere nei nomi degli elementi chimici, anch’essi costituiti da poche lettere, il loro simbolo, il loro numero atomico, il peso atomico e altre notizie che li riguardavano».
Ad esempio, acqua in Raubser è “ebas”. Poche lettere, che ci dicono però molto: B e S sono idrogeno (xavaB) e ossigeno (navaS). La E iniziale significa che gli atomi di idrogeno sono due, mentre la A che l’atomo di ossigeno è uno. Dunque, abbiamo la parola, ma anche la formula chimica.
Un metodo simile lo utilizza per la parte geografica. I nomi degli Stati ci danno diverse informazioni, come il continente di appartenenza, la loro sigla, i kmq di superficie e perfino la posizione della capitale indicando latitudine e longitudine. Il Modesmac, che forse in italiano conoscete come Brasile, ci indica che appartiene al continente americano (le ultime due lettere, AC), la grandezza del territorio e la posizione della capitale Brasilia. Anche qua, basta imparare delle regole piuttosto semplici e saper leggere in Raubser. Cosa che al momento ovviamente sa fare solo Luigi.

Luigi ha anche risolto l’annoso problema del plurale maschile in italiano: c’è il genere promiscuo, dunque ad esempio i neonati maschi sono “li bent”, le neonate femmine “li bentien”, i neonati al plurale sia maschi che femmine “li bentiel”.
Mentre scorre le pagine sul computer appaiono migliaia di parole ancora da completare. «Non ho difficoltà a creare parole: considera che nell’Iveonte ho inventato 1845 nomi, tra personaggi e luoghi». In effetti, scorrendo l’infinita lista dei nomi e dei luoghi dell’Iveonte si rimane affascinati dalla varietà e dall’inventiva: Kenust, Beriesk, Pornuk, Dolren, Admur (dio degli omosessuali), Kronel, Nurdok, Kreop (dio degli strapazzi, ex dio delle illusioni), Loifen, Oskup, Puzzud, Rapos, Parakosm (universo parallelo di Kosmos), Opirgos, Landipur, Xoran e così via. Il suo gatto invece si chiama Pippo.
“Hai kurobik dont du aipl bulpes, voil guzev be udr paiur setalis gu kus unil oxeop ut taesi xez ser”
«Io e mia moglie non abbiamo avuto figli. Ma forse è stato destino: questo mi ha permesso di avere più tempo per scrivere».
Chiedo a Lisa se ha letto l’Iveonte: «Certo, due volte! E mi è piaciuto molto».
Lei è la sua lettrice ufficiale da sempre, di tutte le sue opere, e l’ha aiutato a correggere alcuni refusi e a rendere più scorrevoli alcuni passaggi. Ma chi altro ha letto i 15 milioni di caratteri dell’Iveonte? La colossale epopea è stata letta di sicuro da una loro vicina di casa, («l’ha letto tutto d’un fiato», mi dice Luigi) e da una “amica di Facebook”, sua lettrice appassionata da vent’anni che negli anni ha seguito l’evolversi di questa galassia-libro. Di altri lettori o lettrici, non abbiamo notizie certe.
Gli chiedo se in tutti questi anni qualcuno, un collega magari, un amico o un parente, si sia interessato all’Iveonte, e anche alle sue poesie e alla Raubser.
«In verità, mai nessun mio collega si è preso la briga d’interessarsi alle mie opere. Al riguardo, non sono mai riuscito a capire se per gelosia, per invidia oppure perché davvero non avevano tempo di leggerle. Posso affermare che lo stesso atteggiamento c’è stato nei confronti delle mie opere anche da parte di amici e parenti. Quando gliene parlavo, mai nessuno si è fatto prendere dalla curiosità di conoscere le cose che scrivevo».

In una delle sue poesie introspettive tratte dalla raccolta “Sensazioni dall’inconscio” Luigi scrive: “Sono stufo di stare con persone che forse non meritano la mia stima e la mia fiducia, non interessandosi esse a tutto ciò che scrivo; anzi, preferiscono ignorarlo e si comportano come se io non ponessi mai mano alla penna”.
Allo stesso tempo, in passato ha tentato contatti con case editrici: ma si sa, gli scrittori sono tanti, i manoscritti sono migliaia e figuriamoci quando arriva un malloppo come L’Iveonte… Dopo diverse delusioni Luigi ha optato per la vendita online e l’autopubblicazione on demand: il libro cartaceo viene stampato solo nel momento in cui viene ordinato. Questo permette oltretutto di poter correggere eventuali errori o modificare alcuni passaggi e avere versioni sempre aggiornate dei volumi. Ciò significa che teoricamente esistono più versioni dell’Iveonte, anche se non sappiamo quante ce ne sono in giro – e se ce ne sono.
Con gli scrittori l’argomento libri venduti è sempre molto delicato, quindi mi ci avvicino con i piedi di piombo, ma capisco subito che a Luigi non interessa affatto.
«Più che il denaro che potrei guadagnare dalla vendita dei miei libri, in primo luogo m’interessa la loro lettura da parte di un vastissimo pubblico».
Per questo motivo nel 2005 intraprende un’altra missione senza limiti: mettere online tutte le sue opere. Si tratta di migliaia di pagine – per l’esattezza 2171 –, un sito enorme e labirintico, che decide di costruirsi da solo (www.luigiorabona.com). Impara il linguaggio del Web, l’HTML, e costruisce il suo sito che da allora aggiorna costantemente man mano che completa gli scritti o trova degli errori. Se vuole modificare una singola parola, individua la pagina che gli interessa tra le migliaia presenti, la apre con blocco note e interviene direttamente sul codice. Un metodo efficace e artigianale da abile scriba digitale.
«Ho imparato tutto da solo» ci tiene a precisare.
Gli chiedo di mostrarmi i file originali dell’Iveonte. Davanti ai miei occhi scorrono migliaia di file HTML: è un po’ come guardare il codice sorgente di Matrix. Le mappe che illustrano le galassie dove il romanzo è ambientato, con l’impero dell’ottaedro, l’impero del tetraedro, la galassia neutrale e tutti i vari pianeti, le ha realizzate con Paint.
Chiedo a Luigi se ha mai pensato di tradurre l’Iveonte nella lingua Raubser.
«Devo considerare la tua domanda uno scherzo? La Raubser non è uno dei tanti tentativi di lingua artificiale. In tutti i sensi, essa è superiore a qualsiasi lingua parlata. Quindi dovrei impararla perfettamente prima di tradurre Iveonte nella lingua Raubser. Inoltre, data anche la mia tarda età non avrei né le forze fisiche né il tempo materiale».

Lascio Luigi e Lisa Beatrice e il mare del Salento e qualche ora dopo sono in aeroporto che attendo il mio volo. Sfoglio ancora le poesie e capito su una intitolata “Oramai ci siamo”, dove Luigi affronta il tema per eccellenza, la morte: “Oramai si affretta il tempo che mi obbligherà ad affrontare la fase finale della mia esistenza” esordisce. Per poi prendere atto che a un certo punto le sue forze lo abbandoneranno e così “ogni intraprendenza attiva della mia prolifica fantasia”.
Guardo una sua mail di qualche mese fa con alcune fotografie di lui da bambino e da ragazzo. Nella mail mi raccontava della sua infanzia: “Mia madre era casalinga e mio padre aveva un piccolo negozio. Avevano conseguito entrambi la licenza di quinta elementare. Io e le mie due sorelline Rita ed Elvira ci ammalammo di una infezione viscerale. Loro morirono, mentre io ero quasi morto, per cui cominciarono a piangermi. Allora intervenne questo mio parente e gridò a tutti: Egli non è morto; anzi, vivrà e diventerà il più grande uomo di Parete!“.
Luigi proviene da una famiglia numerosa e ha avuto un’infanzia costellata da morte e dolore. “In famiglia, oltre a me e le mie sorelline morte, c’erano ancora altri sette fratelli più grandi, tre maschi e quattro femmine. All’età di 15 anni, quando frequentava la terza media, una delle sorelle morì di meningite tubercolare. A quel tempo, anch’io, che avevo 6 anni, mi ammalai di tbc, ma nessuno se ne accorse e guarii senza fare alcuna cura. Lo venimmo a sapere solo anni dopo. Io e i miei fratelli in seguito ci ammalammo anche di epatite B: io ero divenuto portatore sano, mentre i miei fratelli ne erano rimasti affetti allo stato latente e morirono di cirrosi epatica, a causa della loro epatite non curata.”
Io e le mie due sorelline Rita ed Elvira ci ammalammo di una infezione viscerale. Loro morirono, mentre io ero quasi morto, per cui cominciarono a piangermi.
Mentre rileggo la mail squilla il telefono: è lui. Penso che voglia sapere se sono già partito, ma invece attacca con una raffica di cifre enormi che non riesco a seguire: un milione e settecentotrentaquattro mila, un milione e ottocentosedicimila e così via, che si mescolano agli annunci degli altoparlanti dell’aeroporto e al chiacchiericcio dei passeggeri in attesa intorno a me.
«Luigi, sono in aeroporto, non ti sento bene, è meglio se mi mandi una mail» gli dico. Pochissimi minuti dopo ricevo una mail con il numero esatto dei caratteri di ogni singolo capitolo dell’Iveonte. Riprendo in mano la poesia di prima, “Oramai ci siamo”, che si conclude con i seguenti versi: “Del mio tiepido essere vivente non potrà che restare soltanto il ricordo di amici e parenti”.

Se togliamo le poche ore di sonno, e le ore di veglia passate a scrivere, Luigi ha trascorso più tempo nel mondo dell’Iveonte che in quello reale. La sua opera smisurata e fantastica sembra il frutto di un totale rifiuto della “vita per ciò che è”. Partendo da Parete, Luigi ha fatto della propria vita un romanzo, e di un romanzo la propria vita. E finché ci sarà anche un solo lettore o lettrice che ne sfoglierà qualche pagina, quel romanzo esisterà. E se è vero, come amava ripetere un grande artista salentino, che “non bisogna produrre capolavori, ma essere capolavori”, Luigi Orabona è senza dubbio un capolavoro.
Morte in Raubser si dice kaud, dunque vita duak.

